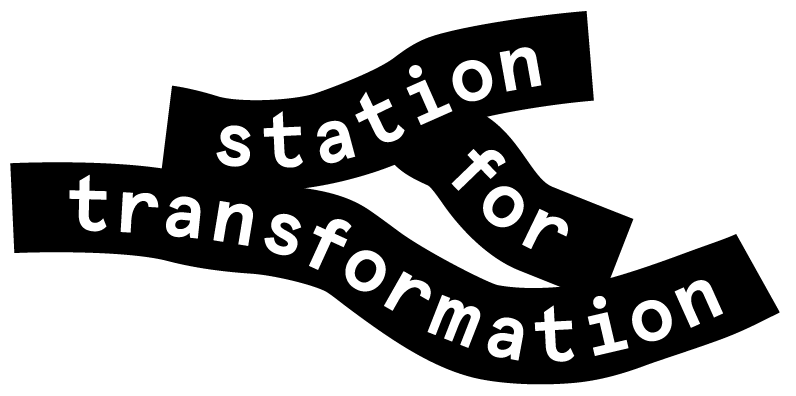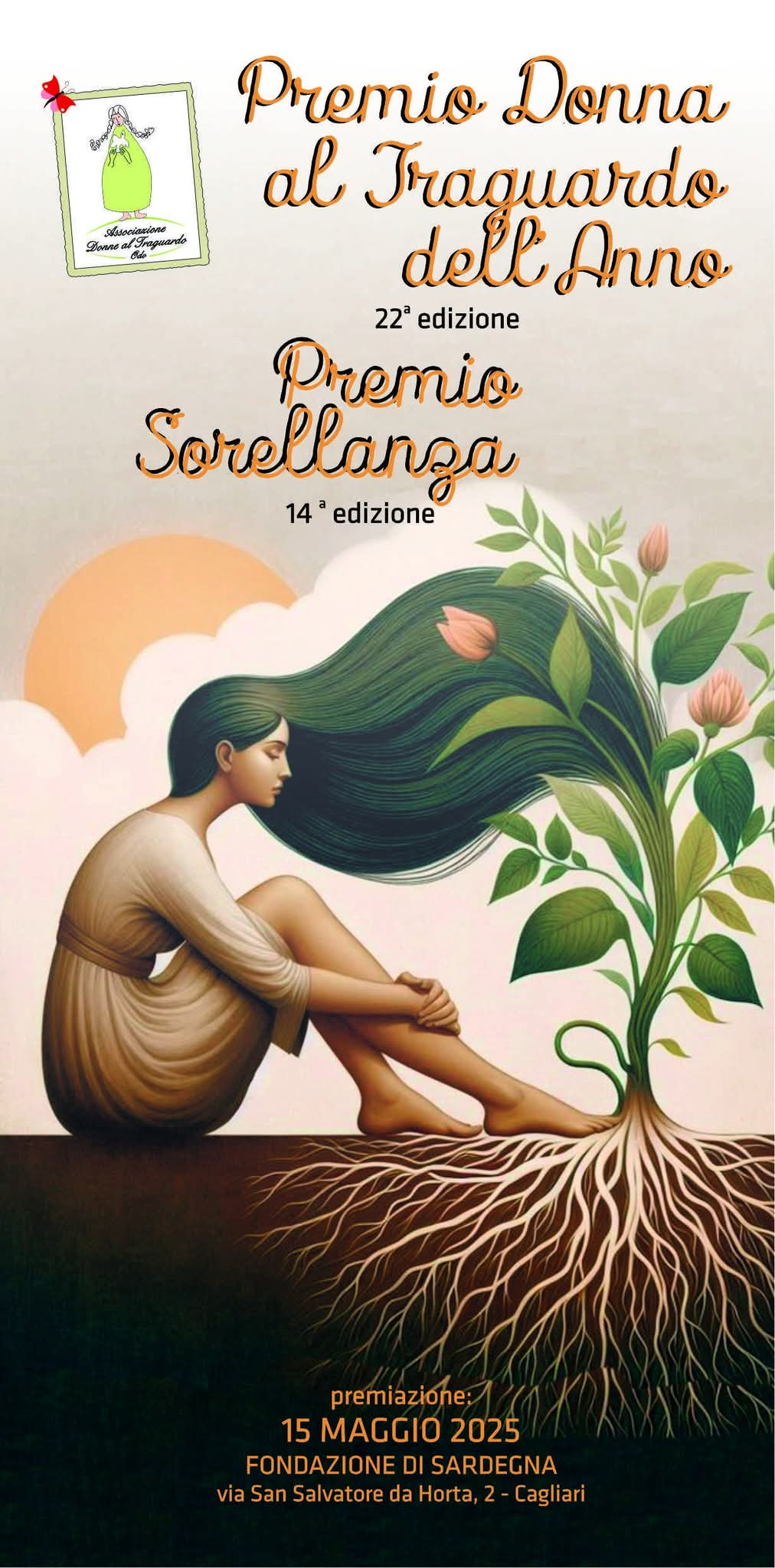Il tempo sociale e il tempo della marginalità: un connubio problematico.
Vite sospese, vite appese, vite ferme
di Carmelo Bruni
Professore Associato di Sociologia, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma
Intervento del Professor Bruni alla presentazione del Rapporto ONDS 2024.
Vorrei partire da una prima considerazione. La presenza di persone emarginate non costituisce un epifenomeno della nostra società, una sorta di incidente del tutto casuale rispetto alla normalità di una società sana, che funziona, equa e socialmente giusta. Al contrario, la loro presenza ci richiama ad un senso di responsabilità come collettività, è una responsabilità della nostra società, così come l’abbiamo costruita, la viviamo e la governiamo.
Perché dico questo?
Perché l’emarginazione è un fenomeno sociale, e ogni fenomeno sociale è il frutto di una relazione tra gli Io che sono i protagonisti della loro esistenza e gli altri che sono la società, il contesto. Per ciascun ego esistono oggi nel mondo 8 miliardi di alter, in Italia 60 milioni. Posto questo è chiaro che ogni persona si trova di fronte a condizionamenti sociali – non determinismi, non siamo marionette di cui qualcuno tira i fili – condizionamenti che influenzano fortemente il suo progetto esistenziale, vincolandolo, a volte indirizzandolo. È un po’ il gioco della fune.
Se questo è vero in generale, lo è ancora di più per le persone più deboli, più fragili, all’interno della nostra società. Più un soggetto è fragile – emotivamente, cognitivamente, nel capitale culturale, umano, e sociale – più è esposto agli effetti dei processi sociali e più facilmente ne rimane travolto, perché è più vulnerabile.
C’è da chiedersi, quindi, se vale la pena dare una mano alle persone più fragili. Normalmente la risposta a questa domanda dipende dalla responsabilità che assegniamo alla persona nell’aver prodotto la sua situazione: se la riteniamo responsabile della sua condizione, se cioè questo è il risultato di una scelta, allora siamo in generale meno propensi ad aiutarla.
Ma le persone fragili sono responsabili della loro situazione? Un disabile psichico lo è? Un minore vittima di abusi? O una donna vittima di violenza? Un immigrato che non è accolto? Uno che ha da giovane ha fatto uso di sostanze? O un adulto che deve pagare gli errori di gioventù?
Dal momento che dedichiamo così poche risorse e attenzione alla vita di chi è in strada, ciò ci dimostra che siamo propensi a ritenerli responsabili della loro condizione.
Il fatto di essere così pronti a giudicare e a responsabilizzare gli altri della loro condizione, ci fa prendere atto del fatto che oggi viviamo all’interno di un modello culturale che ci vuole far credere che le stesse leggi della sopravvivenza che dominano nella savana o nella giungla sono valide anche nella vita degli esseri umani: homo homini lupus est (Hobbes, da Plauto).
Ma siamo davvero certi di questo? Cioè che valga anche nel contesto umano una “legge naturale” che si impone agli esseri umani?
Guardiamoci intorno: cosa c’è di veramente naturale intorno a noi, qui nella nostra città? Gli alberi? I parchi e i giardini? Nelle Ville? Questi sono “arredo urbano”, cioè luoghi verdi deputati al piacere umano, al tempo libero, al divertimento: cioè un salotto o un soggiorno esterno, non sono “natura”.
È dal 1999, da quando il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen introdusse il termine “Antropocene”, che siamo consapevoli di vivere in una nuova epoca geologica, caratterizzata dal fatto che l’azione dell’uomo sta modificando gli equilibri climatici, chimici, biologici e geomorfologici del sistema Terra. Ma se l’essere umano è stato capace di modificare ciò che gli è esterno e lo sovrasta, la Natura, di cui ci accorgiamo quando si ribella, ancora di più noi esseri umani dobbiamo essere consapevoli di quanto siamo responsabili di come abbiamo costruito ciò che ci è più proprio: la nostra società.
Giungiamo così ad un primo punto fisso: noi esseri umani facciamo il mondo nel quale viviamo.
La nostra azione è motivata culturalmente; è frutto di scelte culturali, cioè di una precisa visione del mondo, fatta di valori (cioè le cose importanti per cui vale la pena vivere) e leggi derivate, che determinano la creazione di un ben definito sistema sociale e culturale, un sistema umano, un ambiente umano che si confronta con l’ambiente naturale.
Un sistema sociale può essere, se vogliamo usare questo termine, darwinianamente interpretato come un ambiente umano anziché ecologico, un ambiente però soggetto ad una selezione determinata non da leggi naturali, ma da leggi sociali, cioè scelte da noi come collettività, che hanno però nella nostra esistenza la stessa forza delle leggi naturali. Gli usi, i costumi, gli habitus per dirla alla Bourdieau, hanno la stessa forza nella nostra vita delle leggi naturali nella vita degli animali.
A questo punto urge sollevare un’altra domanda: che tipo di società vogliamo? in che tipo di “città” vogliamo vivere?
La situazione che ci troviamo a commentare oggi, che parliamo di accoglienza di senza dimora, ci dimostra nei fatti che ad oggi il sistema sociale e culturale che abbiamo creato è un sistema escludente, che tiene ai suoi margini, scartandola, una parte della nostra collettività, e quale di questa? la sua parte più debole e più fragile.
Che loro però siano deboli e fragili è vero, ma è vero SOPRATTUTTO rispetto al sistema sociale e culturale che noi abbiamo creato. Non è detto, cioè, che la stessa persona che è debole e fragile in un certo sistema, lo sia necessariamente in tutti i sistemi, dipende dalla rete di protezione e di inclusione che è costruita intorno a lui o lei.
Questo sistema sociale e culturale, caratterizzato da un particolare sistema istituzionale che determina per esempio quali servizi sono da considerarsi “Commons (beni comuni, beni collettivi)” da tutelare e quali invece no e quindi decide chi deve essere aiutato: la minore età è un bene? La salute? Di chi?; è un sistema contraddistinto da un certo assetto dei mercati che stabiliscono quali sono i prodotti e i servizi da offrire alla collettività e che questa può scegliere, determinando chi vende e cosa si vende, e questo comporta che il sistema è contrassegnato da un preciso modello produttivo che determina quali lavori possono essere svolti in Italia, che caratteristiche deve avere una persona per sperare di essere occupata; questo sistema è strutturato in un sistema di norme culturali che stabiliscono qual è, per esempio, il posto delle donne in relazione agli uomini (possono lavorare fuori oppure debbono stare a casa? Possono studiare oppure lo debbono fare solo gli uomini? Qual è il ruolo dei giovani rispetto agli adulti e agli anziani, quale quello dei disabili in una società di normodotati, quello degli stranieri c’è spazio per loro? – ma chi è straniero? Anche qui, i confini li stabilisce la natura o gli esseri umani? La linea che vediamo disegnata sulle cartine geografiche e che separa una nazione dall’altra la ritroviamo delineata concretamente sul terreno o è solo il frutto di una convenzione sociale? Cioè della “cultura”? Cioè delle scelte e degli accordi tra gli esseri umani? E allora torniamo alla società dell’inclusione come una scelta relazione, fondata su un accordo tra esseri umani: ma gli accordi possono essere rivisti.
Questo sistema sociale e culturale dà vita quindi a un particolare assetto della società che crea un “ambiente umano”, che condiziona i parametri dell’accettabilità o del rifiuto, che stabilisce la normalità e l’anormalità, chi è alla moda e chi è fuori moda, insomma chi è dentro e chi è fuori dai parametri di accettabilità sociale.
Insomma, credo che sia sempre più chiaro come i fenomeni sociologici nei quali siamo immersi siano fenomeni voluti dagli uomini in base al modello culturale cui si ispirano.
Trasposto nel nostro discorso odierno questo ci porta alla considerazione della povertà non come un fenomeno sociale frutto di scelte individuali, ma come il risultato dell’interazione tra un particolare assetto del sistema sociale e le caratteristiche di tutte le persone che lo compongono. Ovviamente, chi è adatto al sistema, ce la fa, ma alcune persone, in questa relazione, le più deboli rispetto al sistema, finiscono per essere poste ai margini: la povertà è quindi l’esito di un incontro che non ha funzionato, di una relazione mancata. La povertà è quel fenomeno sociologico che, data una particolare configurazione storica del sistema sociale e culturale, determina che certe caratteristiche sono da ritenersi ritenute accettabili per essere inclusi nel sistema: chi non corrisponde alle caratteristiche richieste, quelle considerate giuste, rimane fuori e viene considerato responsabile di queste sue caratteristiche: la condizione di povero è colpa sua, del fatto che non si è reso adatto al sistema.
Non è il povero, quindi, ad essere il problema: il povero è quello che subisce quel particolare assetto della società, che è un assetto non solo sociale ed economico, ma soprattutto culturale.
Il povero diventa colpevole della sua condizione solo all’interno di una particolare rappresentazione del fenomeno della povertà e delle caratteristiche della persona povera.
Se le rappresentiamo come indolenti, nullafacenti, furbe, parassite, è chiaro che non ci può essere spazio per l’aiuto. Chi lavora in questo settore sa benissimo che ci sono anche “gli indolenti”, di sicuro non ci sono i “senza dimora per scelta”.
Non c’è alcuna scelta nello stare in strada: soprattutto quando fa freddo e non sai come ripararti dal gelo e dalla pioggia, non hai un posto dove mangiare, dormire ed espletare i bisogni corporali. Non c’è alcun fascino nella vita di strada, se non nella letteratura e nel cinema, o nella fantasia di chi non conosce la strada.
C’è un’altra sfaccettatura della vita di strada, quella che riguarda il rapporto tra senza dimora e tempo. La vita del senza dimora è una vita svolta in un tempo diverso da quello sociale. Esistono tempi diversi nella strada. Quando la città dorme, chi è in strada è sveglio: non per minacciare, chi vive in strada non è “l’uomo cattivo” che turba i sogni dei bambini, ma forse è proprio il bambino che ha paura di addormentarsi in strada, semplicemente perché addormentarsi in strada può essere pericoloso. E allora di notte si rimane svegli, per evitare di essere depredati di quel poco che si ha, e di giorno, quando la città è produttiva, lavora, si arricchisce, il senza dimora ne approfitta per dormire. Perché la strada a quell’ora è frequentata, e i malintenzionati diventano visibili agli occhi di tutti, quindi non osano derubarti.
Ma come possiamo conciliare i tempi del lavoro, della società produttiva, della società della conoscenza e della concorrenza, con i tempi del senza dimora, che sono sfalsati rispetto a loro: la città si sveglia di giorno, il senza dimora si sveglia di notte, questi tempi differenti non possono incontrarsi: al senza dimora restano poche opportunità per l’inclusione in un tempo diverso rispetto a quello al quale è costretto.
Una seconda dimensione è quella del tempo che scorre all’interno delle strutture, nel percorso di accoglienza e sostegno. Emerge dalla letteratura e dalle testimonianze degli operatori delle strutture di accoglienza l’irriducibile diversità e unicità delle traiettorie esistenziali di chi è senza dimora. Potremmo dire che “Le strade che portano alla strada seguono itinerari diversi”. Proprio gli “itinerari diversi” sono quelli che caratterizzano i percorsi che hanno una destinazione comune, la strada.
Così è necessario fare in modo che il tempo di chi è ospitato nelle strutture segua ritmi diversi da quelli moderni.
Noi abbiamo dimenticato che nel passato abbiamo vissuto all’interno di un tempo diverso: siamo talmente abituati ai ritmi incalzanti del nostro tempo, che abbiamo dimenticato che può esistere anche un tempo diverso: un tempo in cui domina la lentezza. Per noi oggi vale l’associazione tra lentezza e vecchiaia, viceversa, quella che associa giovinezza a novità e velocità. Questo idea del tempo come scorrere lento è invece presente e fatto proprio dalle strutture che si prendono cura dei senza dimora: il tempo dell’intervento è centrato sulla persona, non ha i caratteri dell’efficienza moderna, non deve “produrre” risultati, deve consentire a chi è in difficoltà di riappropriarsi di Sé, e nel Sé il tempo ha una funzione cruciale: quella di consentire di tornare ad essere protagonista della propria vita, della propria progettualità esistenziale, di tornare a poter scandire i ritmi della propria esistenza sapendo conciliare il proprio tempo interno con i ritmi sociali.
Il tempo all’interno dei servizi assume un carattere differenziato e flessibile, che pur perseguendo un fine, che è la riappropriazione di sé e della propria vita da parte dell’ospite, cerca, quantomeno di riuscire, ad adattarsi ai tempi dell’ospite.
All’interno dei servizi, quindi, viene modificato l’approccio con il tempo. Emerge una relazione autonomizzata col Tempo nella Relazione. Agli ospiti viene garantita la possibilità di appropriarsi del proprio tempo, sia di quello interno che di quello esterno: il tempo del senza dimora è diverso, potremmo dire in realtà che il tempo interno di ogni essere umano segue ritmi diversi da quelli scanditi dalla società; non è detto, cioè, che ciascuno di noi accetti di seguire i “riti di passaggio” socialmente definiti.
Al tempo stesso, il tempo è una risorsa strategica sulla quale fa perno anche l’operatore sociale nel percorso di sostegno ed aiuto. Potremmo definirla come la capacità di attesa del momento giusto: viene in mente il tempo come durata di cui parla Bergson. È un tempo esteso, insensibile ai ritmi dell’efficienza, fuori dai canoni della partitura sociale. È un tempo che pone attenzione alle esigenze della persona, non a quelle della rendicontazione dell’efficacia dell’intervento.
Contribuisce a scardinare questa logica temporale efficientista anche il modo con cui viene declinata la relazione tra operatore e ospite. Una logica efficientista vorrebbe che il tempo dell’intervento venga deciso dalla struttura di accoglienza. Emerge invece che nelle strutture di accoglienza gli operatori sottolineino come sia importante lasciarsi scegliere dall’ospite. Non si tratta di scegliere il miglior prodotto della filiera ma, al contrario, di saper aspettare – cioè, si tratta di usare il tempo a proprio vantaggio, non di esserne sopraffatti – per permettere agli ospiti di uscire fuori di sé.
Questo uso del tempo permette di aiutare le persone a raccontarsi. Il tempo lento, non efficientista, permette alla persona di leggere o rileggere la propria storia, consentendole la riappropriazione di un rapporto con se stessi e il proprio vissuto, che favorisce la riorganizzazione della persona e del suo progetto esistenziale.
La conseguenza di questo è un tempo non lineare: è un tempo fatto di andate e di soste, di ritorni indietro e di ripartenze. La logica è diversa, è centrata sulla persona. E l’esistenza, la vita, segue percorsi non lineari, non sono scandite da uno spartito, ma dall’improvvisazione, spesso dal caso, nei casi drammatici dalla sincope.
C’è poi un tempo molto moderno, quello dell’immigrato, la cui vita resta sospesa, interrotta, ferma (Paolo Boccagni, Vite Ferme. Storie di Immigrati in attesa, Il Mulino, 2024). Può essere interessante ripercorrere la vicenda di Moussa Diarra, l’immigrato ucciso a Verona da un poliziotto.
Moussa Diarra aveva 26 anni e veniva dal Mali. Moussa aveva avuto riconosciuto un permesso umanitario nel 2017, che aveva una durata di due anni. Nel 2020 Moussa ebbe la necessità di rinnovare quel permesso. Dai suoi documenti risulta che la questura gli avesse fissato diversi appuntamenti: il 13 dicembre del 2021, il 31 gennaio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 5 maggio, il 26 maggio, il 14 luglio e il 26 agosto del 2022. Queste date, indicate e poi via via cancellate, dicono che Diarra si era sempre presentato e aveva ricevuto, ogni volta, un appuntamento successivo.
Questi cedolini per i rinnovi servono a mantenersi in regola in attesa di risposte che tardano ad arrivare. «Danno spesso però e solo in teoria, la possibilità di trovare un lavoro ed essere assunti in modo regolare, non sono riconosciuti da altri enti e ostacolano anche la richiesta di un codice fiscale». Il risultato, «è che si bloccano o diventano estremamente difficili procedure per noi ovvie come l’apertura di un conto corrente in banca, l’ottenimento di un contratto di lavoro, l’attivazione di uno Spid, l’iscrizione anagrafica, la possibilità di avere un medico di base o anche solo la possibilità di mettersi a cercare una stanza o una casa dove vivere».
Pensiamo a cosa significhi vivere in attesa di una risposta, ogni giorno, per almeno 1 o 2 anni di fila: ogni mattina una nuova speranza, ogni sera una nuova delusione: dovremmo domandarci, che fine fa l’integrità del Sé? Si sbriciola? E con questo forse il proprio equilibrio mentale? Non sta forse proprio in quella burocrazia inefficace e non governata l’origine della causa del malessere? Non è forse l’assenza di una politica migratoria ciò che produce, come nel caso della povertà, l’esclusione?
Infine, un ultimo tempo da considerare per i senza dimora è il tempo o i tempi della fuoriuscita.
Anche in questo caso non abbiamo a che fare con le logiche efficientiste, ma con quelle della protezione e della solidarietà.
Dobbiamo fare i conti con la consapevolezza che ci sono persone che non possono essere reimmesse nella società come se fossero un “capo rimesso a nuovo”: tra i senza dimora non esiste il vintage. Con alcuni di loro non possiamo pretendere un’autonomia gestionale e personale che non sono in grado di agire. Tra loro ci sono, cioè, persone la cui fragilità non è eliminabile oltre un certo limite; di conseguenza, l’unica alternativa all’uscita da una struttura protetta è la strada.
In questo caso si alza forte una domanda da parte degli operatori, la domanda che questi si pongono è: perché va considerato come negativo il desiderio di restare nella struttura di accoglienza? Perché solo l’uscita è da considerarsi positiva?
Il restare, l’andare e il tornare costituiscono tutti movimenti che fanno parte integrante di un percorso, quello di uscita dall’isolamento, che è proprio del senza dimora. L’obiettivo che emerge non è tanto legato ad un risultato, quanto a un’opportunità: quella di riemergere, questo si, dall’esclusione.